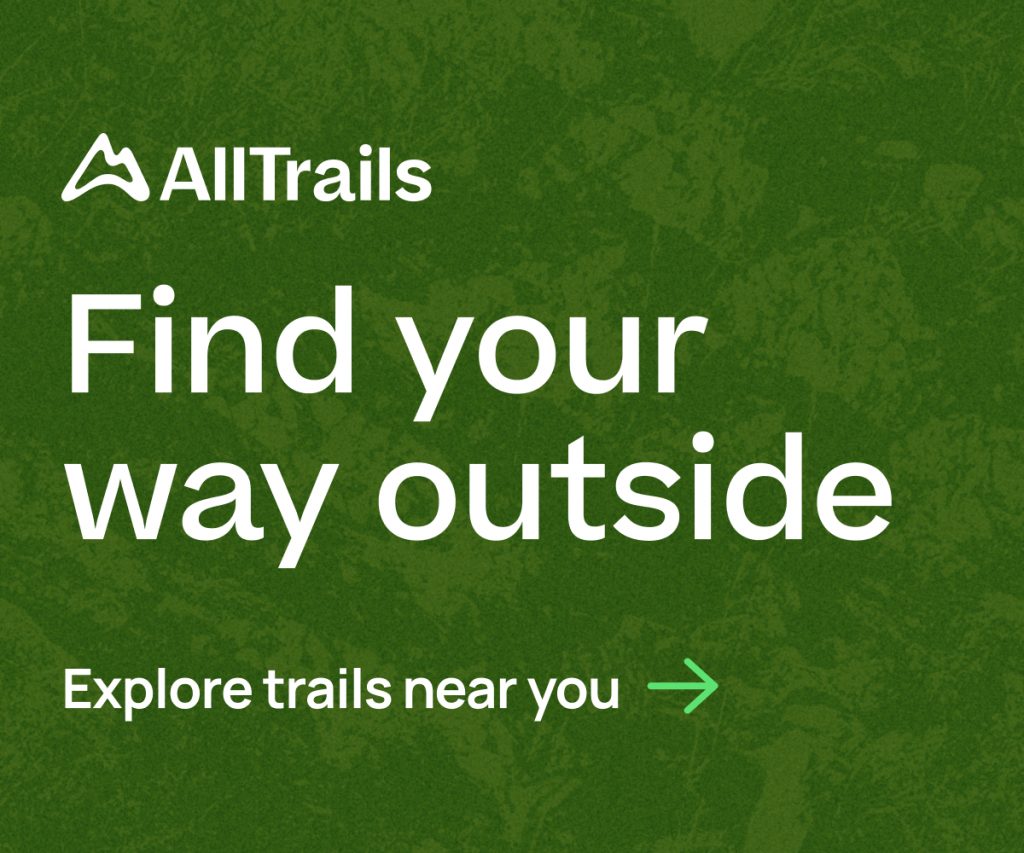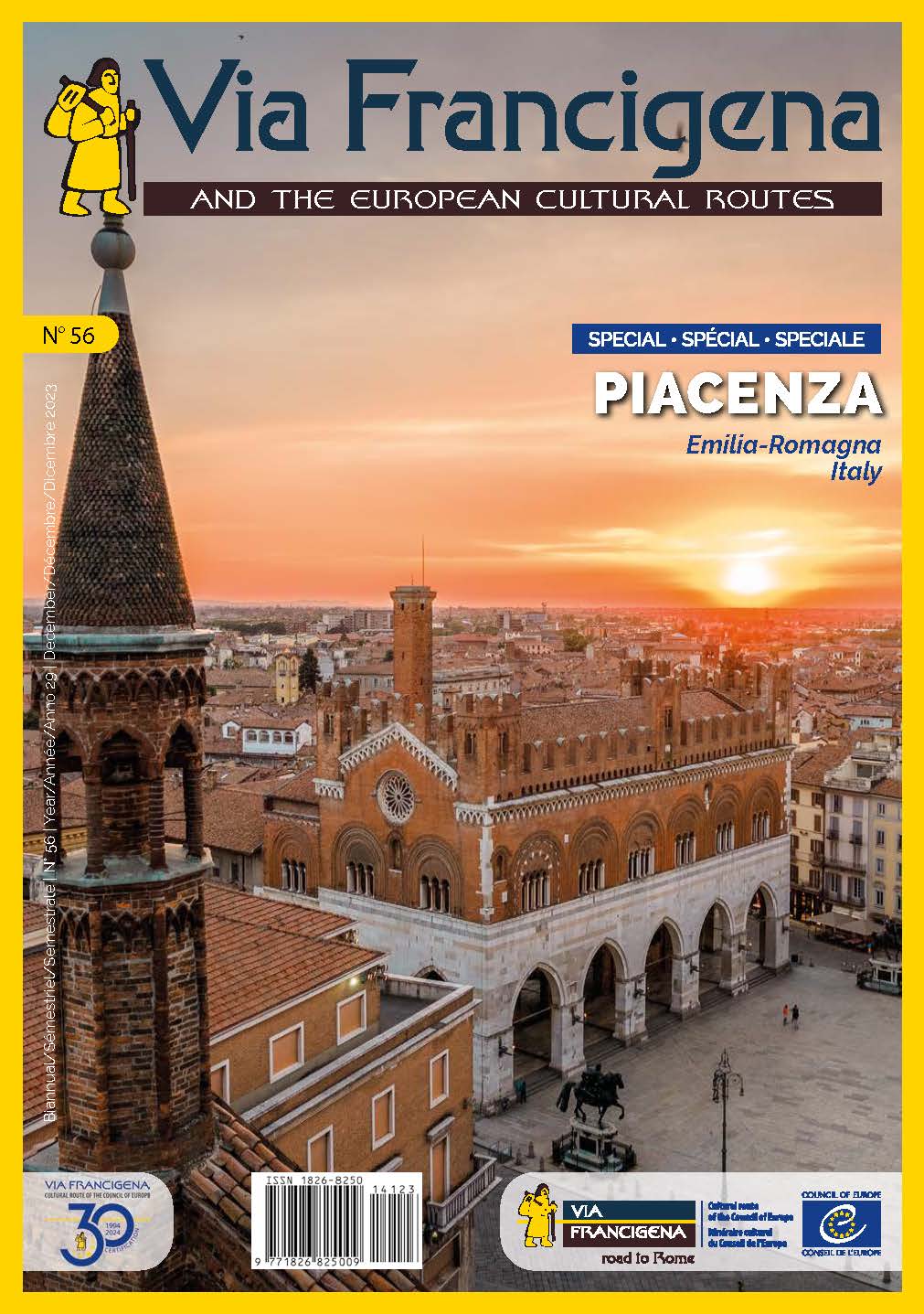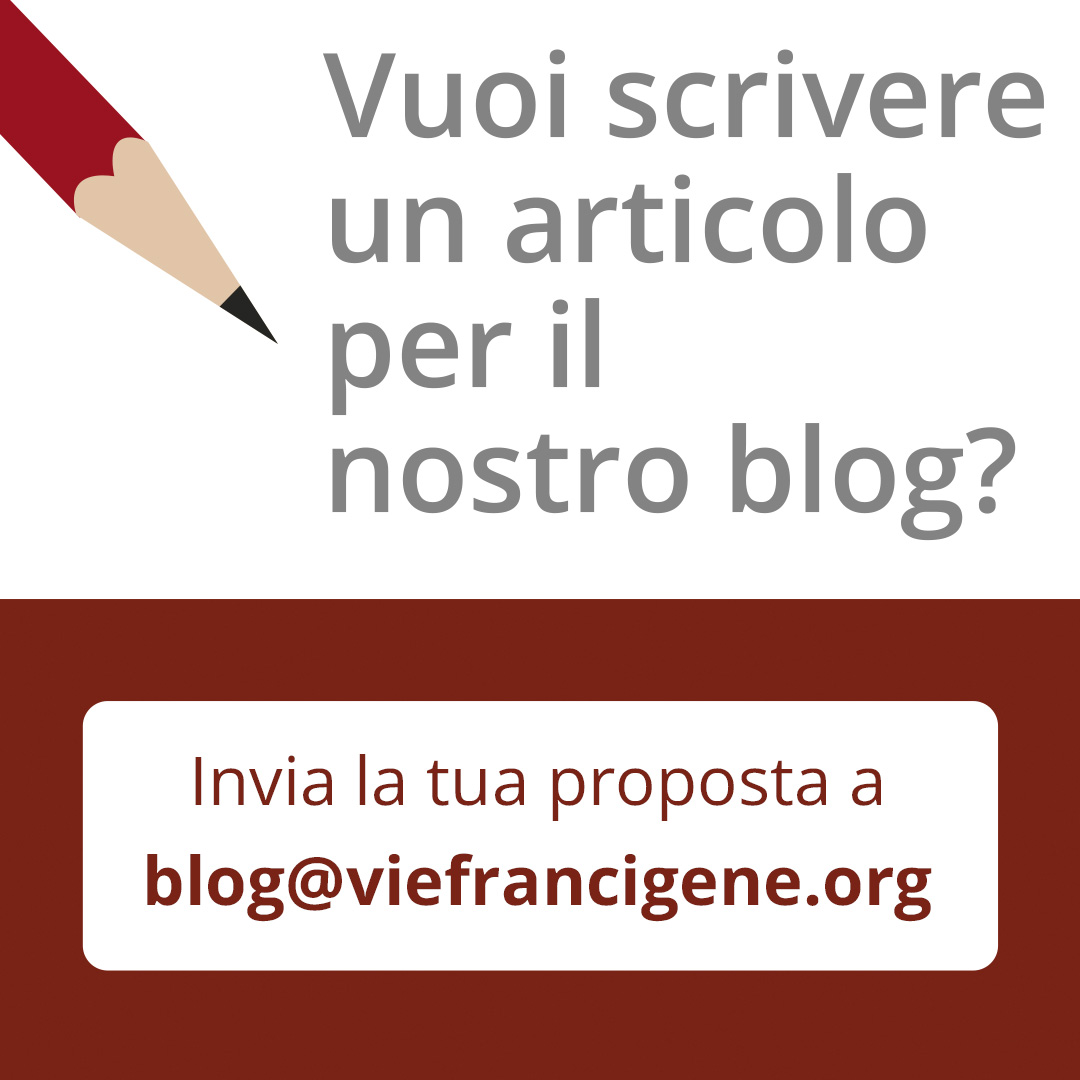Dopo la Puglia, la regione Campania è il secondo capitolo del nostro diario di viaggio che racconta tutto il percorso della Via Francigena in occasione del Giubileo 2025.
Con i suoi 3.200 km, lo storico itinerario medievale attraversa cinque Stati (Inghilterra, Francia, Svizzera, Città del Vaticano e Italia), sedici regioni e più di seicento comuni, come dettagliamo nel percorso. A partire dal Kent, nel Regno-Unito, tocca le regioni Haute-de-France, Grand Est e Bourgogne-Franche-Comté, in Francia; i Cantoni Vaud e Vallese, in Svizzera; le regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Puglia, in Italia. Infine, a Roma lo Stato del Vaticano, luogo-simbolo del Giubileo.
Per questi speciali regionali realizzati in collaborazione con Regione Lazio, abbiamo deciso di risalire lo stivale e di raccontare la Via Francigena da sud a nord, portandoti con noi alla scoperta di ogni regione, per immergerci nelle sue bellezze paesaggistiche, storiche e gastronomiche. Non mancheranno tanti consigli di viaggio sul cammino, con il meglio delle tappe e alcune curiosità.
Pronti a mettervi in cammino con noi?
Partiamo!
La Via Francigena in Campania si estende per circa 125 km, articolandosi in 9 tappe che attraversano paesaggi suggestivi tra storia e natura. Il percorso inizia a Sessa Aurunca, al confine con il Lazio, e termina a Buonalbergo, importante crocevia dell’antichità. Il cammino, che fa parte della Via Francigena nel Sud, presenta una difficoltà moderata, con alcuni tratti caratterizzati da dislivelli significativi, soprattutto nelle aree collinari e montuose dell’entroterra. Lungo il tragitto si incontrano borghi storici, siti archeologici e testimonianze del passaggio dei pellegrini medievali diretti verso Roma.
Tabella dei contenuti
Storia e spiritualità: un percorso tra Sessa Aurunca, Riardo e l’Arco di Traiano

Il cammino attraverso la Campania è un viaggio che intreccia storia, arte e spiritualità. Un primo punto di sosta è la Cattedrale di Sessa Aurunca, un esempio splendido di architettura romanica, edificata tra il 1103 e il 1113 e dedicata ai Santi Pietro e Paolo. Al suo interno si trovano sculture a bassorilievo e mosaici in stile bizantino, che arricchiscono il valore artistico e spirituale del luogo. Sempre a Sessa Aurunca, si trova il teatro romano, costruito tra il II e il I secolo a.C., ma scoperto solo nel 2001. Il teatro offre una vista straordinaria sulla baia di Gaeta, rendendo la visita ancora più affascinante.
A breve distanza, il Castello di Riardo, che si trova in un borgo medievale, ha origini longobarde e risale all’849, quando fu costruito per difendere la Contea di Capua. Successivamente ristrutturato sotto i Normanni, il castello è il simbolo di un territorio che ha attraversato numerose dominazioni e conflitti, ma ha anche custodito con orgoglio il suo patrimonio culturale e spirituale.
Infine, a Benevento, città ricca di storia, si trova l’Arco di Traiano, eretto tra il 114 e il 117 d.C. per celebrare l’apertura della Via Traiana, una variante della Via Appia che accorciava il percorso tra Roma e Brindisi. Questo imponente monumento è un testimone della grandezza dell’antica Roma e della sua rete infrastrutturale. Questi luoghi offrono una straordinaria panoramica sulla storia della Campania, tra arte, architettura e tradizioni secolari.
- Piccola curiosità – Cattedrale di Sessa Aurunca
Nel marmo della Cattedrale di San Pietro sono raccontate storie bibliche, dalla Genesi agli Atti degli Apostoli. Si trovano anche le rappresentazioni di animali reali e fantastici, simboli di fede o paura, come leoni, draghi, grifoni, serpenti e la balena di Giona, un bestiario che crea un mondo che mescola realtà e fantasia.
Cultura: tra leggende e tradizioni di Benevento

Benevento, situata nel cuore dell’Appennino campano, è una città che ha visto il passaggio di diverse civiltà, tra cui gli Osci, i Sanniti, i Romani e i Longobardi. Con un importante patrimonio archeologico e monumentale, è famosa per la sua posizione strategica tra il Mar Tirreno e l’Adriatico.
Secondo la leggenda, la città fu fondata da Diomede, ma storicamente si attribuisce la sua fondazione agli Osci, successivamente dominata dai Sanniti. Durante l’epoca romana, Benevento divenne un’importante colonia, grazie alla via Traiana e alla sua posizione lungo la via Appia.
Dopo un periodo di declino dovuto a invasioni barbariche, Benevento divenne un ducato Longobardo e un importante centro della Chiesa. La città fu poi parte del Regno di Napoli, passando tra vari domini durante le lotte dinastiche. Nel 1860, dopo l’occupazione dei Garibaldini, Benevento entrò a far parte del nuovo Regno d’Italia.
Dell’epoca romana rimangono l’Arco di Traiano e il teatro romano, che poteva contenere fino a diecimila spettatori, inoltre si conservano le terme di San Cristiano, l’anfiteatro e l’Arco del Sacramento.
All’epoca longobarda risale invece la Chiesa di Santa Sofia, edificata nel 760, che, unica nel suo genere grazie alla disposizione delle colonne e alla pianta particolare, è patrimonio dell’UNESCO.
Il centro abitato si trova in una vasta conca circondata da colline. A ovest, oltre la Valle Vitulanese, si erge il massiccio del Taburno Camposauro, le cui vette, viste dalla città, ricordano la figura di una donna sdraiata, conosciuta come la “Dormiente del Sannio“.
- Piccola curiosità – Le streghe di Benevento
Benevento è nota anche come la “città delle Streghe”. Pietro Piperno fu uno dei primi a parlare delle streghe a Benevento, nel suo libro “De nuce maga beneventana”, probabilmente influenzato dai riti pagani dei Longobardi. Si dice, infatti, che un tempo, vicino al Ponte Leproso, ci fosse un noce dove le streghe si radunavano per fare incantesimi. Le leggende si sono poi intrecciate con la storia della tribù dei Samentes, adoratori della foresta. Queste credenze si sono radicate nel tempo, diventando parte della cultura locale, come dimostrano la mela Annurca di Sant’Agata e il liquore Strega, entrambi legati a ricette “magiche”. Oggi, luoghi come il Ponte Leproso, l’Obelisco egizio, e la zona del Teatro Romano sono simboli della magia di questa città. Per chi è appassionato di occulto, la “Notte delle Streghe” celebra ogni anno queste leggende, offrendo un’esperienza unica nel cuore della magia beneventana.
Natura: le colline del Sannio e il paesaggio campano

Il tratto della Via Francigena che attraversa la Campania regala ai pellegrini un paesaggio naturale che si fonde armoniosamente con la storia e la cultura del luogo. Le colline del Sannio, nella provincia di Benevento, con i loro dolci pendii, offrono uno spettacolo mozzafiato. Il nome “Sannio” deriva dalla presenza dei Sanniti, che hanno vissuto in questi luoghi nel VII e VI secolo a.C. Qui, tra i sentieri immersi nel verde, si respira l’anima autentica e orgogliosa delle comunità locali. Tra le montagne, si trovano numerosi piccoli borghi, ognuno con una propria identità, animati da produttori, ristoratori e artigiani che custodiscono le tradizioni locali.
Il cammino si snoda tra dolci colline, fitte aree boschive, campi coltivati e panorami montuosi, offrendo scorci mozzafiato sulla campagna campana. Si attraversano il Parco Regionale di Roccamonfina-Foce Garigliano, con i suoi boschi di castagni e querce, e tratti che costeggiano fiumi e vallate ricche di biodiversità. La varietà di ecosistemi, unita alla presenza di specie vegetali e animali tipiche del Mediterraneo, rende il percorso un’esperienza immersiva nella natura incontaminata del Sud Italia.
Importante è anche la cultura agricola di queste zone, che arricchisce ulteriormente il paesaggio. Più di 11.000 ettari di vigneti adornano la terra, e centinaia di cantine offrono la possibilità di esplorare e degustare alcuni dei migliori vini della regione. Questo cammino non è solo un viaggio fisico, ma anche sensoriale, che unisce la bellezza naturale alla tradizione enologica e gastronomica locale, rendendo ogni passo un incontro con la storia, la natura e i sapori autentici del territorio campano.
- Piccola curiosità – Borgo San Lupo
Non solo Benevento, ma tutto il territorio del Sannio è accompagnato da miti e leggende legate al mondo della stregoneria. Il ponte delle Janare, invece, appena fuori dalla città, nel borgo di San Lupo, racconta la storia di una bella ragazza che fu accusata di stregoneria da un corteggiatore che aveva respinto e quindi fatta annegare nel fiume dagli abitanti del paese. La leggenda vuole che, ancora oggi, chi si affaccia da quel ponte venga trascinato giù dalla ragazza, avvertendo un’irrefrenabile attrazione.
Gastronomia: i sapori della Campania sulla Via Francigena
Quando si parla della Campania, una delle prime cose a cui si pensa è il cibo: in viaggio sulla Via Francigena diventa d’obbligo gustare i sapori locali che si incontrano lungo il cammino!
E così partiamo dalla pasta allo scarpariello, uno dei piatti più amati: una pasta tradizionale con pomodoro, aglio, peperoncino e formaggio, semplice ma ricca di sapore. Questo piatto affonda le sue origini nel mondo rurale e povero, dove gli ingredienti erano pochi, ma ogni famiglia aveva la sua variante segreta.
- Piccola curiosità: il nome “scarpariello” deriva dal termine “scarparo”, che significa calzolaio, perché si dice che questo piatto fosse consumato dai lavoratori manuali, che apprezzavano la sua energia e la semplicità. Il piatto era anche facile da preparare, con ingredienti sempre a portata di mano.
Ma quando si mangia è d’obbligo accompagnare il tutto con un buon vino e la Campania ha la soluzione perfetta per accontentarci anche in questo con il meraviglioso Aglianico del Taburno DOCG, un vino robusto che racconta la storia della viticoltura in queste terre. Il suo sapore ricco e tannico si accompagna perfettamente ai piatti tipici della regione.

- Piccola curiosità: secondo la tradizione, l’Aglianico del Taburno veniva considerato una “bevanda divina” dagli antichi romani. Alcuni storici raccontano che l’imperatore Nerone fosse un grande appassionato di questo vino, che veniva prodotto già all’epoca nell’area circostante Benevento.
Arriviamo al dolce con gli struffoli, piccole palline fritte ricoperte di miele e confetti colorati, sono un must della pasticceria campana, tipici del periodo natalizio ma apprezzati in ogni stagione. La loro preparazione affonda le radici nella tradizione greco-romana, e si dice che furono proprio le antiche popolazioni greche a introdurre questa dolce usanza sulle coste campane.
- Piccola curiosità: gli struffoli venivano preparati nelle case nobiliari come simbolo di prosperità e abbondanza durante le festività. Ancora oggi, la loro preparazione è un atto che unisce le famiglie campane.
Infine, un’altra prelibatezza golosa che si può provare sulla Via Francigena è la torta mora, con il suo impasto morbido e il profumo di arancia, rappresenta un dolce che incarna la tradizione campana, perfetto per concludere il viaggio all’insegna dei piaceri della tavola.
- Piccola curiosità: si dice che la torta mora sia nata in una piccola pasticceria di Benevento, e che il suo nome derivi dal colore scuro dell’impasto, che ricorda la buccia della mora. Oggi, la torta è simbolo della tradizione dolciaria campana e viene preparata con amore e pazienza durante le festività.
Idee di cammini per un ponte o un weekend
Itinerario di 2 giorni (Alife – Telese Terme)
- 1° giorno: Il primo giorno prevede il cammino da Alife a Faicchio (19,3 km), che si snoda a partire da questa città sorta ai piedi del Massiccio Matese, la cui creazione è circondata da molte leggende. Il cammino, per la maggior parte asfaltato e piuttosto semplice, prosegue lungo la campagna, accompagnandoci fino al borgo di Faicchio, dove si staglia il Castello Ducale.
- 2° giorno: Il secondo giorno si presenta di nuovo piuttosto rilassante, con un cammino semplice di 12,5 km, da Faicchio a Talese Terme. Una volta superato il ponte romano, si prosegue ai piedi del Monte Acero, attraverso i boschi e si giunge a Talese Terme. Questa città è famosa per il suo complesso idrotermale, l’impianto venne aperto nel 1883.

Itinerario di 3 giorni: (Minturno – Statigliano)
- 1° giorno: Si parte da Minturno, ultima città del Lazio, e si procede in direzione di Sessa Aurunca (24,2 km). Entrando in Campania si viene sorpresi dalla cornice dell’Appennino, con i rilievi montuosi e le vallate verdi. Passando per i campi coltivati, si giunge a Suio, dove è possibile fare una breve sosta per ammirare la Chiesa di Santa Maria in Peninsulis, costruita nel 200 e l’area termale. Infine, si giunge a Sessa Aurunca, di cui abbiamo parlato sopra, città che diede i natali a Gaio Lucilio, poeta della satira, ricca di storia e architettura.
- 2° giorno: Il secondo giorno il cammino procede da Sessa Aurunca a Teano (15,3 km), procedendo verso l’uscita da Sessa Aurunca, una delle più suggestive della Via Francigena, dal centro storico si avanza lungo uno sterrato che scende verso una vallata verde. Il percorso si snoda sulle pendici del vulcano spento di Roccamonfina e arriva infine a Teano attraverso il basolato della Via Adriana. Da vedere i resti del Teatro Tempio dedicato ad Apollo, il museo archeologico e le chiese di San Paride ad Fontem e San Pietro in Aquariis.
- 3° giorno: Per il terzo giorno il cammino prevede la tratta da Teano a Statigliano (24,6 km), un percorso per la maggior parte pianeggiante e su asfalto, ai piedi dei Monti Trebulani. Lungo il tragitto si visitano i borghi medievali di Riardo, Pietramelara e Roccaromana. Successivamente si giunge alla Torre Normanna, edificata intorno al 1100 e ricostruita dopo i bombardamenti, e infine si giunge a Statigliano.

Itinerario di 6 giorni (Teano – Benevento)
- 1° giorno: Il primo giorno di questo cammino prevede la tappa da Teano a Statigliano (24,6 km). Vedere terza tappa “itinerario di 3 giorni”.
- 2° giorno: Il secondo giorno si parte da Statigliano in direzione di Alife (17,2 km), una tratta breve, che pèrò si rivela pericolosa sul finale, consigliamo infatti di utilizzare il treno che ferma a Dragoni. Si scende quindi fino alla pianura del Volturno, attraversando Baia e Latina. Giunti ad Alife si respira la sua storia millenaria, visitando l’Anfiteatro, il Criptoportico e il Foro, ma anche la Cattedrale di Santa Maria Assunta e il museo archeologico dell’antica Alifae.
- 3° giorno: Il terzo giorno si procede da Alife a Faicchio (19,3 km). Vedere prima tappa “itinerario di 2 giorni”.
- 4° giorno: Il quarto giorno si va da Faicchio a Talese Terme (12,5 km). Vedere seconda tappa “itinerario di 2 giorni”.
- 5° giorno: Il quinto giorno il cammino va da Talese Terme a Vitulano (16,1 km), una tappa impegnativa a causa dei frequenti dislivelli. Sul tragitto si incontra Solopaca, resa famosa dai vini Doc. Si giunge infine a Vitulano, dove, tra un bicchiere di Falanghina e di Pecorino Dop, si può visitare il Convento della Santissima Annunziata, fondato da San Bernardino da Siena e contenente la pala d’altare, da lui stesso regalata, che raffigura l’Annunciazione.
- 6° giorno: Il sesto giorno, infine, si va da Vitulano a Benevento (17,2 km). Questa tratta, per la maggior parte pianeggiante, porta dagli Appennini alla piana beneventana. Al fondo della Valle si incontra il fiume Calore, da cui parte una lunga pista ciclopedonale, che passa attraverso l’oasi naturalistica Lipu e arriva fino alla periferia di Benevento (per informazioni su Benevento leggere il paragrafo 2 “Cultura: tra leggende e tradizioni di Benevento”).

Qualche consiglio
1. Prepara il tuo equipaggiamento
- Scarpe da trekking: la scelta delle scarpe è fondamentale, soprattutto per le lunghe distanze. Opta per scarpe robuste e comode, con buona traspirabilità e un buon supporto per i piedi. Scarpe da trekking leggere sono ideali per i percorsi più lunghi. Altra tip: più lo zaino cresce di peso, più è importante che la calzatura abbia la caviglia alta, per supportare la flessione della schiena. Qui qualche consiglio grazie al nostro partner Garmont .
- Zaino: scegli uno zaino comodo e non troppo pesante. Controlla che sia dotato di cinghie regolabili e di una buona ventilazione. È fondamentale non sovraccaricare il bagaglio, bisogna cercare di non superare il 10-15% del proprio peso corporeo; porta solo l’essenziale. Qui qualche idea consigliata da Ferrino.
- Abbigliamento: porta con te abiti traspiranti, comodi e leggeri. A seconda della stagione, aggiungi una giacca impermeabile per proteggerti dalla pioggia o dal vento, e un cappello o un berretto per il sole. Se non sai dove trovarli guarda qui.
- Bastoncini da trekking: sono molto utili per ridurre lo sforzo sulle ginocchia, specialmente in tratti di salita o discesa. Eccoli qui.

2. Pianifica le tappe e gli itinerari
- Distanza e tempo: ogni giorno di cammino prevede distanze che variano dai 15 ai 25 km. Se non sei abituato a camminare lunghe distanze, pianifica tappe più corte per iniziare. Una buona idea è percorrere l’itinerario in più giorni, in base alle tue capacità.
- Dove pernottare: lungo il percorso troverai numerose strutture di accoglienza, come ostelli, B&B, agriturismi e conventi. In alcuni luoghi puoi anche usufruire dell’ospitalità in rifugi per pellegrini. Prenota in anticipo, specialmente nei periodi di alta stagione (primavera ed estate).
- Come raggiungere la regione: sono tantissimi i modi per raggiungere la Campania, ma non tutti sono green o a basso impatto e, soprattutto, non tutti sono convenzionati con la Via Francigena. È per questo che noi consigliamo di raggiungere la regione in FlixBus o con i treni Trenitalia. Entrambi, infatti, offrono uno sconto del 10% ai possessori della Credenziale ufficiale.
- Adattabilità: non tutte le tappe hanno la stessa difficoltà. Sii flessibile e, se necessario, adattati alla situazione. Ricorda che il cammino non è una gara, ma un’esperienza di scoperta personale e spirituale.
- La guida della Campania: per evitare spiacevoli inconvenienti, suggeriamo di portare con sé anche la guida della Via Francigena nel Sud di Sandy Brown, o La Via Francigena nel Sud di Terre di Mezzo, dove, oltre agli itinerari, si possono trovare tantissimi consigli per affrontare il cammino al meglio. (LINK)
- La Credenziale: ogni pellegrino che si rispetti ne possiede una. Qui la Credenziale ufficiale della Via Francigena, una compagna importantissima da portare lungo la Via per poter usufruire di sconti e agevolazioni e per tenere traccia dei propri passi con i timbri originali delle località del percorso.

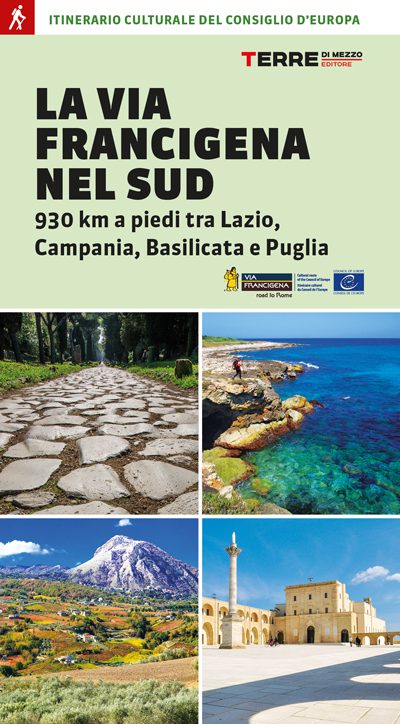
3. Sicurezza e Salute
- Acqua e cibo: porta sempre con te almeno 2 litri d’acqua. Alcune tappe del cammino potrebbero non avere fonti facilmente accessibili, quindi, è importante rifornirsi nelle tappe principali. Non dimenticare di portare anche snack energetici come frutta secca, barrette di cereali e noci.
- Protezione solare: il sole del sud Italia può essere molto forte, soprattutto in estate. Usa una crema solare con protezione alta, occhiali da sole e un cappello.
- Riposo: ascolta il tuo corpo. Non esitare a fare delle pause e a riposarti quando necessario. I muscoli e le articolazioni possono soffrire durante il cammino, ecco perché prendersi dei momenti di recupero è importante.
Articolo pubblicato nell’ambito dell’intervento: Fondo Sviluppo e Coesione – Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del Ministero italiano della cultura (Scheda 33 – Via Francigena – Azioni trasversali. Trasmissione scheda progetto “Piano di comunicazione e promozione),