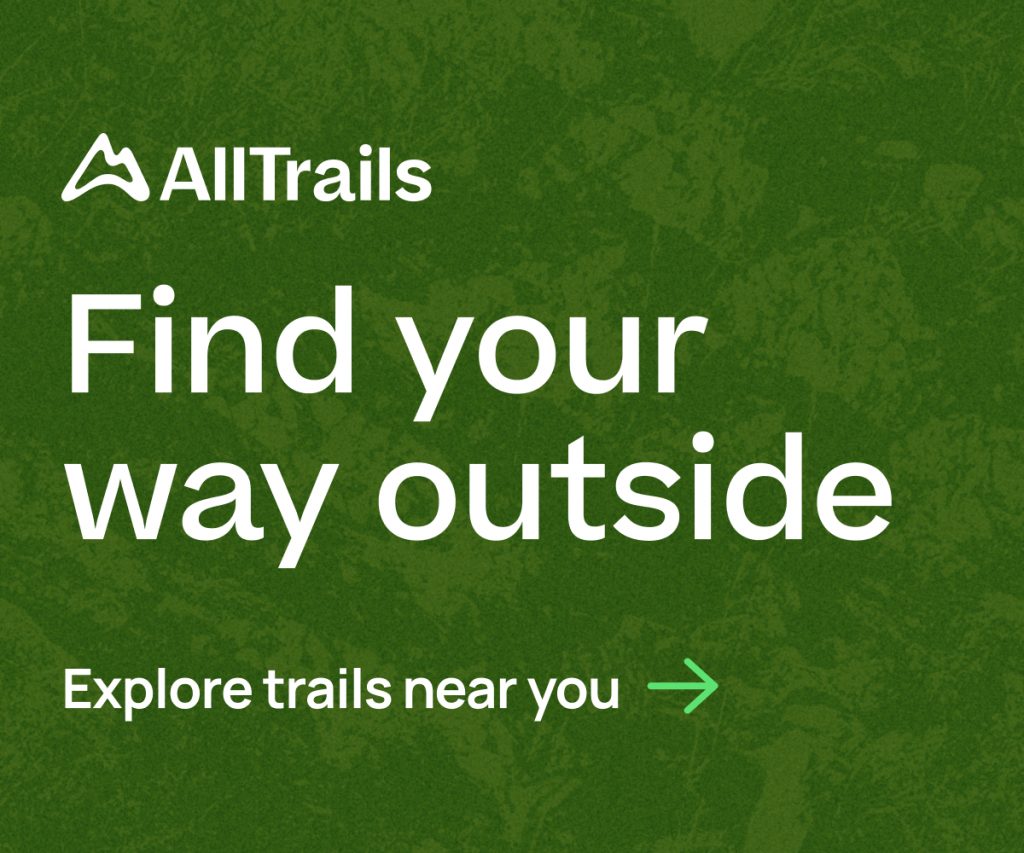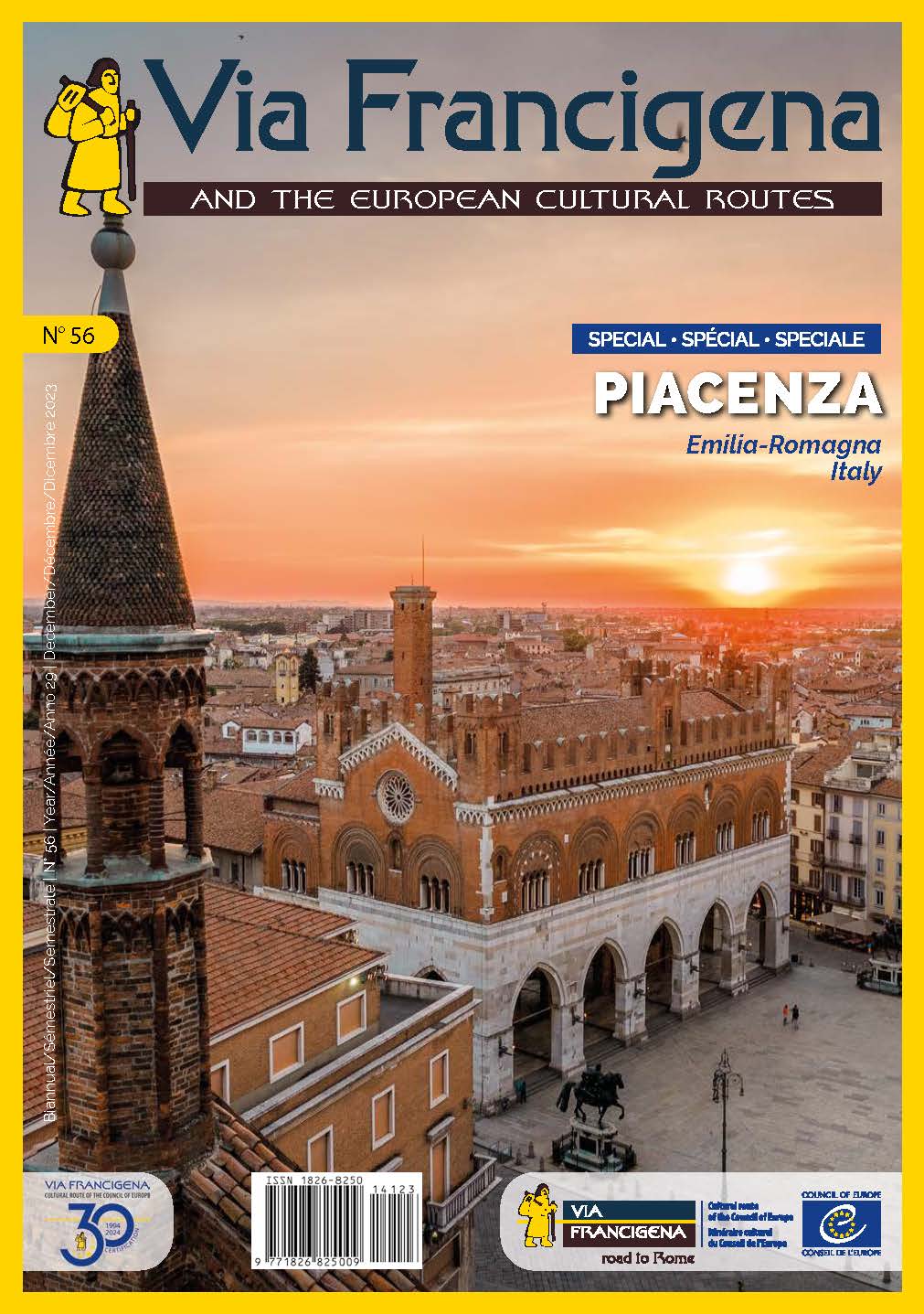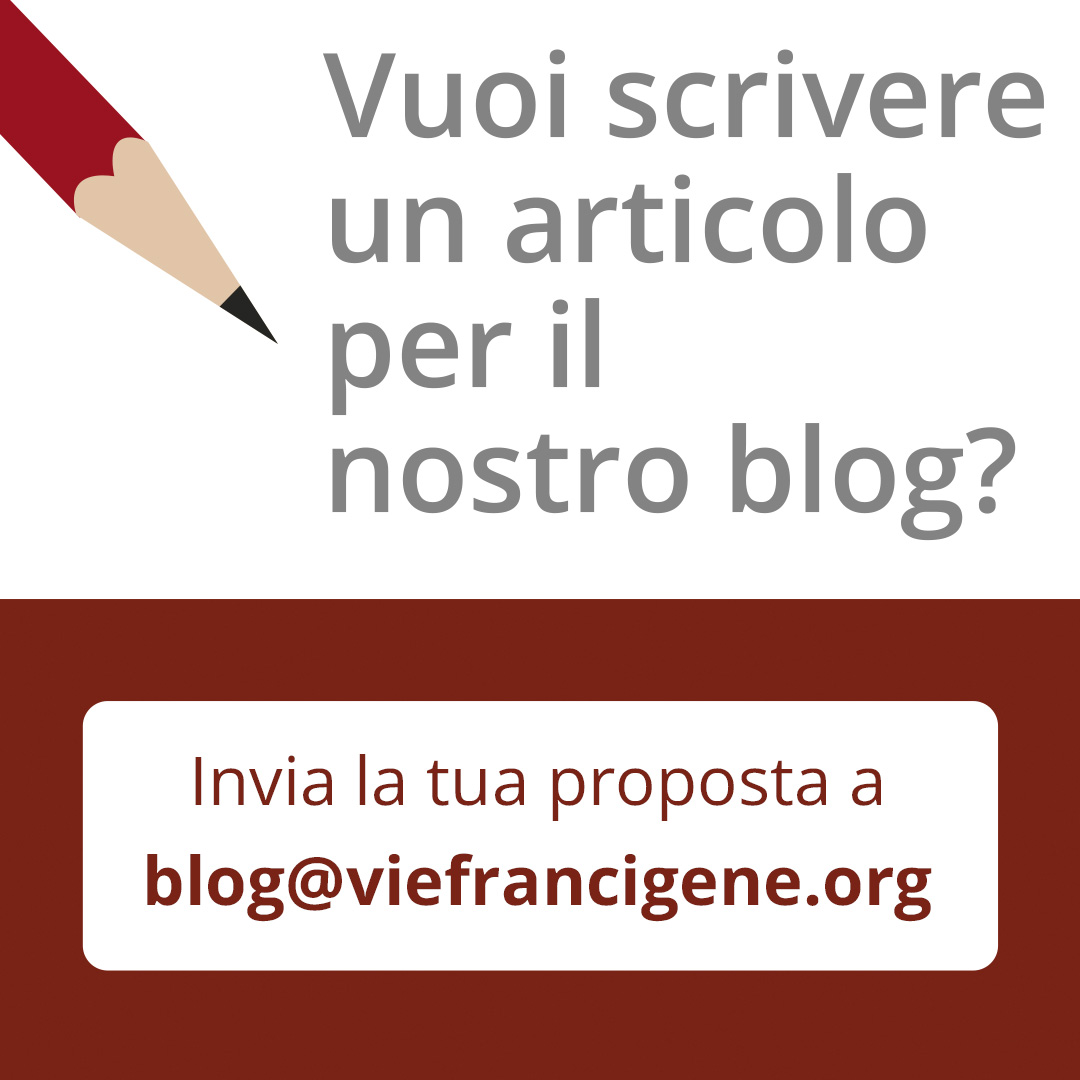Dopo la Puglia e la Campania, eccoci con il terzo capitolo, questa volta a tema Lazio Sud, del nostro diario di viaggio che racconta tutto il percorso della Via Francigena in occasione del Giubileo 2025.
Con i suoi 3.200 km, lo storico itinerario medievale attraversa cinque Stati (Inghilterra, Francia, Svizzera, Città del Vaticano e Italia), sedici regioni e più di seicento comuni, come dettagliamo nel percorso. A partire dal Kent, nel Regno-Unito, tocca le regioni Haute-de-France, Grand Est e Bourgogne-Franche-Comté, in Francia; i Cantoni Vaud e Vallese, in Svizzera; le regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Puglia, in Italia. Infine, a Roma lo Stato del Vaticano, luogo-simbolo del Giubileo.
Per questi speciali regionali abbiamo deciso di risalire lo stivale e di raccontare la Via Francigena da sud a nord, portandoti con noi alla scoperta di ogni regione, per immergerci nelle sue bellezze paesaggistiche, storiche e gastronomiche. Non mancheranno tanti consigli di viaggio sul cammino, con il meglio delle tappe e alcune curiosità.
Pronti a mettervi in cammino con noi?
Partiamo!
La Via Francigena nel sud del Lazio rappresenta la porta d’ingresso al sud Italia, si estende per oltre 2 00km, articolandosi in 12 tappe che attraversano paesaggi suggestivi tra storia e natura. Il percorso inizia a Roma, punto di arrivo dei pellegrinaggi dal nord, e termina a Minturno, prima tappa della Campania. Il cammino, che fa parte della Via Francigena nel Sud, incarna un incontro di storia, spiritualità, tradizioni, gastronomia e leggende.
Storia spirituale: l’uscita da Roma e l’inizio del cammino verso il Sud

Il Lazio, e in particolare la città di Roma, sono il cuore pulsante di questo antico percorso. Roma, infatti, era, e rimane, il punto di arrivo di molti pellegrini che partivano dall’Europa per giungere alla tomba di San Pietro, ma è anche il luogo da cui inizia un altro tratto significativo del cammino: l’uscita dalla città e l’inizio del viaggio verso il sud.
Nel Medioevo, le vie di pellegrinaggio e commercio in Europa erano fondamentali e lo sono rimaste fino all’arrivo delle ferrovie nel XIX secolo. Santiago, Roma e Gerusalemme rappresentavano i principali centri di una rete che collegava città, mercati e porti. La Via Francigena, infatti, attraversando in verticale tutto il continente, non era un semplice percorso da Canterbury a Roma, ma un vero e proprio “asse attrezzato“.
Chi da Roma decideva di incamminarsi verso sud poteva scegliere percorsi diversi che in genere si riunivano in due importanti “nodi”: Capua e Benevento. Da qui la direttrice più battuta era l’Appia Traiana, che conduceva verso i porti della Puglia: Siponto, Bari, Egnazia, Brindisi, Otranto, “finis italiae”. Le città costiere pugliesi, come Bari e Brindisi, erano importanti porti per i pellegrini diretti in Terra Santa, un fenomeno che fiorì fino al XIII secolo, quando il pellegrinaggio via mare divenne più comune, con rotte dominate dai Veneziani.
Camminando verso sud, tuttora i pellegrini lasciano la grandezza della Capitale e si addentrano in un paesaggio ricco di spiritualità e storia, che segna un confine simbolico tra il mondo centrale e settentrionale e le terre meridionali, venendo ricompensati dai numerosi monumenti indimenticabili che si possono ammirare lungo il cammino. La Via Francigena prosegue verso luoghi sacri e spirituali, ma anche verso una serie di paesaggi che sono da sempre simboli di resistenza e di tradizione.
Luoghi iconici: l’Appia Antica, Terracina, il Monte Circeo e l’Abbazia di Fossanova

Il tratto del Lazio Sud della Via Francigena è particolarmente ricco di luoghi iconici che legano la storia antica con la spiritualità medievale.
L’Appia Antica, una delle più datate e celebri strade romane, è il primo grande simbolo di questo viaggio. Un cammino che, per secoli, ha collegato Roma con le regioni del sud Italia, ed è ancora oggi un luogo da percorrere per immergersi nella storia dell’Impero Romano e nella spiritualità del pellegrinaggio.
Fu progettata nel 312 a.C. dal censore Appio Claudio Cieco, con l’obiettivo di creare una via rapida che collegasse Roma a Capua, facilitando il movimento delle truppe verso sud durante la Seconda Guerra Sannitica (326-304 a.C.). Successivamente, il percorso venne esteso fino al porto di Brindisi, per garantire un collegamento diretto con la Grecia, l’Oriente e l’Egitto, utilissimo per le spedizioni militari, i viaggi e il commercio. Questo ampliamento rese la Via Appia Antica la “Regina Viarum”, ovvero la regina delle strade, in epoca romana.
Piccola curiosità: “Domine, quo vadis?”
La tradizione narra che proprio lungo l’Appia Antica, durante la sua fuga da Roma per scampare alla persecuzione di Nerone, l’apostolo Pietro incontrò il Cristo e gli chiese “Domine, quo vadis?” – Signore, dove vai? – e che Gesù avrebbe risposto “Torno a Roma a farmi crocifiggere”, al che l’apostolo, pentito, fece marcia indietro. Il momento segnò una delle scene più simboliche della cristianità e sul luogo, al bivio con la Via Ardeatina, a 800 metri da Porta San Sebastiano, per celebrarlo, venne eretta la Chiesa Domine Quo Vadis tuttora meta di pellegrinaggio.
Proseguendo, il pellegrino giunge a Terracina, è una città situata lungo la costa tirrenica, tra Roma e Napoli, nella provincia di Latina. La sua posizione, tra il mare e i monti, la rende particolarmente affascinante, con un perfetto equilibrio tra storia, cultura e bellezze naturali.
Fondata dai Volsci, Terracina vanta una lunga storia che abbraccia epoche diverse, dalle origini antiche ai periodi romano e medievale. In epoca romana, la città era un importante snodo commerciale e di passaggio, grazie alla sua posizione lungo la Via Appia.
Uno dei principali luoghi d’interesse è il Tempio di Giove Anxur, situato sulla cima di una collina, che offre una vista panoramica spettacolare sulla città e sul mare. Il tempio risale al I secolo a.C. ed è uno dei punti più visitati della città. Inoltre, il centro storico conserva resti significativi dell’epoca romana, come il foro e il teatro romano, insieme a tracce del suo passato medievale, come il Castello di Terracina, una fortificazione che testimonia il ruolo difensivo della città.
Il Monte Circeo, un altro simbolo di grandezza naturale, si erge maestoso lungo la costa laziale, all’interno del Parco Nazionale del Circeo e collega l’immaginario del viaggio verso il Sud con la mitologia e le tradizioni locali.
Piccola curiosità: la leggenda del Monte Circeo
Secondo la leggenda, il Monte Circeo è il luogo dove Circe, la maga della “Odissea” di Omero, trasformava gli uomini in maiali, da qui infatti deriva il suo nome. Il mito è ancora presente nelle tradizioni locali, dove le storie di Circe e dei suoi incantesimi sono tramandate di generazione in generazione. La sagoma di questo monte, inoltre, sembra ricalcare quella di una donna sdraiata, che, nell’immaginario, rappresenterebbe proprio la figura della Maga.
Uno dei luoghi più suggestivi del percorso è infine, senza dubbio, l’Abbazia di Fossanova, che accoglie i pellegrini con la sua quiete monastica e la bellezza del suo stile. Situata nel comune di Priverno, in provincia di Latina, nel Lazio e fondata nel 1208, è uno dei principali esempi di architettura cistercense in Italia. La sua costruzione riflette la sobrietà e la funzionalità tipiche dell’ordine, con uno stile gotico che si distingue per la sua eleganza essenziale. L’abbazia è famosa per la sua chiesa, caratterizzata da un’imponente navata centrale e da alte vetrate che permettono alla luce di inondare l’interno, creando un’atmosfera mistica e tranquilla.

Un aspetto di grande fascino è inoltre il chiostro, un ampio spazio aperto circondato da eleganti arcate che offrono un senso di pace e raccoglimento. All’interno, si trovano anche numerosi affreschi e sculture, che testimoniano l’importanza artistica del luogo. Un aspetto particolare della storia dell’abbazia è legato a San Tommaso d’Aquino, che vi morì nel 1274, la cui tomba si trova all’interno della chiesa.
Tradizioni: l’antico ruolo di Roma come centro di partenze per il pellegrinaggio
Roma ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella storia del pellegrinaggio, non solo come capitale dell’Impero Romano, ma anche in quanto cuore spirituale della cristianità. Nel Medioevo, infatti, divenne uno dei principali centri di partenza per i pellegrinaggi verso la Terra Santa e altri luoghi sacri, come Santiago di Compostela. La sua importanza era legata alla presenza delle reliquie dei santi e dei martiri, in particolare quelle di San Pietro e San Paolo, che attiravano migliaia di pellegrini in cerca di salvezza, grazia o redenzione.
La Città era quindi vista come una meta fondamentale del pellegrinaggio medievale, ma non solo come destinazione finale. Erano molti i pellegrini che partivano da qui per proseguire il loro viaggio fino a Gerusalemme e, la Via Francigena, che partiva da Canterbury, in Inghilterra, attraversava l’Europa per arrivare a Roma per poi proseguire verso il sud, ha sempre ricoperto il ruolo di crocevia per i viandanti che attraversavano il Continente.
Questa via non era solo un cammino fisico, ma un vero e proprio viaggio spirituale che univa le tradizioni cristiane dei vari paesi, ma anche le necessità economiche o militari. Roma fungeva da snodo per tutti i pellegrini, che da lì si dirigevano verso sud, molti dei quali percorrevano la Via Appia, come detto poco sopra una delle strade più importanti dell’epoca romana, per arrivare ai porti pugliesi e imbarcarsi verso altri lidi.
Gastronomia: carciofi alla romana e carciofi alla giudia, vini dei Castelli Romani e fragole di Nemi

Il Lazio Sud non è solo storia e spiritualità, ma anche una terra ricca di tradizioni culinarie che raccontano la cultura del territorio. L’alimento più iconico di questa regione, che è il re della tavola romana, detto anche “l’ottava meraviglia di Roma”, è il carciofo. Particolarmente coltivato negli ambienti mediterranei, era apprezzato già dagli Antichi Egizi, per le sue proprietà benefiche e curative, infatti è stato spesso utilizzato nella preparazione di medicine. Non è chiaro chi abbia scoperto per primo questa pianta, ma sicuramente è sempre stata utilizzata in cucina; le leggende parlano dell’uso del carciofo presso gli Antichi Greci, o nei rituali dedicati a Bacco, dove veniva servito insieme a un buon calice di vino.
Quello che è certo è che, a Roma, le ricette per gustarli sono principalmente due e spesso tendono a essere confuse: alla romana e alla giudia.
I carciofi alla giudia, che affondano le radici nella cucina ebraica, sono preparati con dei carciofi paffuti, detti mammole o cimaroli. Una volta puliti, vengono incisi con un coltello, per dare al carciofo un aspetto arrotondato, simile a una rosa, e poi immersi a testa in giù nell’olio di semi bollente, una volta tolti si lasciano riposare e, successivamente, si rimmergono nell’olio per friggerli una seconda volta. La loro croccantezza conquista ogni palato.
Pare che questa ricetta venisse preparata nel ghetto ebraico di Roma tra il 1555 e il 1870, per festeggiare la Pesach, la Pasqua ebraica, che cadeva proprio nel periodo di raccolta di questo ortaggio.
I carciofi alla romana sono preparati con lo stesso genere di carciofi, e gli ingredienti sono molto simili, si aggiungono solo aglio, prezzemolo e mentuccia, che andranno sistemati, una volta tritati, all’interno del carciofo, il quale, capovolto, verrà cotto a fuoco lento in un mix di olio e acqua.
Due specialità che nessun pellegrino può perdersi lungo il cammino!
Come si usava ai tempi degli Antichi Romani, dunque, ogni carciofo va accompagnato con un calice di buon vino e, nel Lazio, i vini dei Castelli Romani, un’area che vanta un’antica tradizione vinicola, accompagnano perfettamente i piatti della zona. Ti consigliamo di entrare in una delle tante fraschette, le tipiche osterie della zona, che trovi sul percorso, dove potrai assaggiare tutte le specialità romanesche e, perché no, concludere il pasto con le famose ciambelline al vino!

Infine, non si può non menzionare la dolcezza delle fragole di Nemi, un frutto che cresce rigoglioso in questa terra, dal sapore unico e inconfondibile, simbolo di un territorio fertile e ricco di prodotti naturali. Le fragoline di bosco sono talmente prelibate che si sono guadagnate una festa tutta loro, la sagra delle Fragole, che si tiene nel comune di Nemi ogni anno dal 1922, la prima domenica di giugno, per celebrare l’inizio del periodo del raccolto.
Piccola curiosità: la leggenda delle fragole di Nemi
Pare che queste fragole siano nate dalle lacrime di Venere che piangeva la morte di Adone, e, successivamente vennero trasformate in piccoli cuori rossi. Sembra anche che fossero dotate di poteri magici, come quello di allontanare i serpenti dai boschi.
Idee di cammini per un ponte o un weekend
Il 2025 si prospetta come l’anno ideale per riscoprire il piacere del viaggio lento e del turismo sostenibile, grazie alle festività che garantiranno numerosi ponti come abbiamo visto qui. Per chi desidera vivere un’esperienza immersiva nella storia, nella natura e nella spiritualità, la Via Francigena nel Lazio rappresenta la scelta perfetta.
Itinerario di 2 giorni (Roma – Velletri)
- 1° giorno: da Roma a Castel Gandolfo, partendo dalla Città del Vaticano, in Piazza San Pietro, dove spesso i cammini terminano, si percorrono 26 km in direzione di Castel Gandolfo. Usciti dalla città, seguendo il basolato romano, si incontrano antiche costruzioni come la Tomba di Geta, il Sepolcro di Priscilla o il Mausoleo di Cecilia Metella. Si giunge quindi in località Frattocchie e, abbandonando la via consolare, si procede in direzione Castel Gandolfo, residenza estiva dei pontefici.
- 2° giorno: il secondo giorno ci si rimette in marcia, 21,3 km, da Castel Gandolfo in direzione Velletri. Il percorso procede verso una fitta area boschiva che fa da contorno al lago Albano, incontrando sul tracciato antiche costruzioni. Sulla seconda parte del percorso si incrocia Nemi, la città delle fragole, dove sarà possibile, se la stagione lo permetterà, assaggiare questa prelibatezza. Si prosegue infine verso Clivo Formello e, da qui, per 5 km in direzione di Velletri.

Itinerario di 3 giorni: (Roma – Cori)
- 1° giorno: da Roma a Castel Gandolfo
- 2° giorno: Castel Gandolfo a Velletri
- 3° giorno: Se si ha a disposizione un giorno in più, da aggiungere al weekend, il tratto da Velletri a Cori, 18,8 km, è il tragitto successivo da percorrere. Uscendo dal centro abitato, si imbocca un sentiero e si transita in prossimità del lago di Giulianello, attraversando l’omonimo centro abitato, si prosegue poi in direzione Colle Illirio, passando per un suggestivo tracciato che porta fino alle pendici del Colle, dove sorge l’antica città di Cori e il magnifico Tempio di Ercole, risalente all’89-80 d.C. in stile dorico, il vero protagonista di questa tratta.

Itinerario di 5 giorni (Abbazia di Fossanova – Minturno)
- 1° giorno: da Abbazia di Fossanova a Terracina, si prosegue per un percorso di circa 20 km, che attualmente è in manutenzione, sostituito da un tragitto alternativo disponibile qui. Star della giornata è sicuramente l’Abbazia, nel comune di Priverno, che fu costruita tra il 1163 e il 1208, è un esempio del primo stile gotico italiano, osservandola è chiaramente visibile una transizione dal romanico al gotico. Curiosa è l’origine del nome, che deriva da una cloaca la quale, alle origini del piccolo borgo, prendeva il nome di Fossanova.
- 2° giorno: il secondo giorno si esce da Terracina e si prosegue superando località Piazza Palatina, incrociando un tratto di basolato dell’Appia Antica e poi 2 km di sterrato, fino a giungere ai piedi di Monte San Biagio. Si scende poi fino al Monastero di San Magno, luogo risalente al VI secolo d.C. che merita una visita da parte dei pellegrini. Il percorso da Terracina termina a Fondi, dopo 22 km, dove è possibile rilassarsi nel centro cittadino o visitare il Castello Baronale Caetani.
- 3° giorno: Il terzo giorno si procede da Fondi a Itri, 15 km di media difficoltà. Da non perdersi, una volta arrivati a destinazione, sono le chiese di San Michele Arcangelo, la chiesa dell’Annunziata e il convento di San Francesco, ma anche una visita alle cosiddette gole di Sant’Andrea, uno dei tratti più suggestivi e meglio conservati dell’Antica Appia.
- 4° giorno: il quarto giorno prevede 21 km da Itri a Formia. Questa cittadina, il cui centro abitato si estende per 9 km lungo la costa, separa il mare dalle vette dei Monti Aurunci. Tra le sue vie, si trova il quartiere medievale “Castellone”, dove si possono visitare chiese, porte dell’antica cinta muraria e vari resti romani. Altri punti di interesse sono la torre cilindrica, il Museo archeologico e la tomba di Cicerone, il famoso oratore romano.
- 5° giorno: Il quinto e ultimo giorno prevede un cammino di 19,8 km, da Formia a Minturno, entrando così ufficialmente in Campania. Lasciando Formia, dopo 4 km ci si inoltra sulla destra spingendosi al limite del Parco Naturale Regionale di Gianole e Monte di Scauri, entrando poi nel territorio di Scauri – Minturno, famoso per la sua meravigliosa costa, ambita dai turisti nei mesi estivi. Superata Marina di Minturno, si prosegue fino alla foce del Garigliano. Una volta risalito il suo corso per 2 km, e giungendo al termine della regione Lazio, si può visitare l’area archeologica dell’antica Minturnae, infine, superato il fiume Garigliano, si entra ufficialmente in Campania.

Qualche consiglio
1. Prepara il tuo equipaggiamento
- Scarpe da trekking: la scelta delle scarpe è fondamentale, soprattutto per le lunghe distanze. Opta per scarpe robuste e comode, con buona traspirabilità e un buon supporto per i piedi. Scarpe da trekking leggere sono ideali per i percorsi più lunghi. Altra tip: più lo zaino cresce di peso, più è importante che la calzatura abbia la caviglia alta, per supportare la flessione della schiena. Qui qualche consiglio grazie al nostro partner Garmont.
- Zaino: scegli uno zaino comodo e non troppo pesante. Controlla che sia dotato di cinghie regolabili e di una buona ventilazione. È fondamentale non sovraccaricare il bagaglio, bisogna cercare di non superare il 10-15% del proprio peso corporeo; porta solo l’essenziale. Qui qualche idea consigliata da Ferrino.
- Abbigliamento: porta con te abiti traspiranti, comodi e leggeri. A seconda della stagione, aggiungi una giacca impermeabile per proteggerti dalla pioggia o dal vento, e un cappello o un berretto per il sole. Se non sai dove trovarli guarda qui.
- Bastoncini da trekking: sono molto utili per ridurre lo sforzo sulle ginocchia, specialmente in tratti di salita o discesa. Eccoli qui.

2. Pianifica le tappe e gli itinerari
- Distanza e tempo: ogni giorno di cammino prevede distanze che variano dai 15 ai 25 km. Se non sei abituato a camminare lunghe distanze, pianifica tappe più corte per iniziare. Una buona idea è percorrere l’itinerario in più giorni, in base alle tue capacità.
- Dove pernottare: lungo il percorso troverai numerose strutture di accoglienza, come ostelli, B&B, agriturismi e conventi. In alcuni luoghi puoi anche usufruire dell’ospitalità in rifugi per pellegrini. Prenota in anticipo, specialmente nei periodi di alta stagione (primavera ed estate).
- Come raggiungere la regione: sono tantissimi i modi per raggiungere la Campania, ma non tutti sono green o a basso impatto e, soprattutto, non tutti sono convenzionati con la Via Francigena. È per questo che noi consigliamo di raggiungere la regione in FlixBus o con i treni Trenitalia. Entrambi, infatti, offrono uno sconto del 10% ai possessori della Credenziale ufficiale.
- Adattabilità: non tutte le tappe hanno la stessa difficoltà. Sii flessibile e, se necessario, adattati alla situazione. Ricorda che il cammino non è una gara, ma un’esperienza di scoperta personale e spirituale.
- La guida del Lazio Sud: per evitare spiacevoli inconvenienti, suggeriamo di portare con sé anche la guida della Via Francigena nel Sud di Sandy Brown (Casa editrice Cicerone), o La Via Francigena nel Sud di Terre di Mezzo, dove, oltre agli itinerari, si possono trovare tantissimi consigli per affrontare il cammino al meglio. (LINK)
- La Credenziale: ogni pellegrino che si rispetti ne possiede una. Qui la Credenziale ufficiale della Via Francigena, una compagna importantissima da portare lungo la Via per poter usufruire di sconti e agevolazioni e per tenere traccia dei propri passi con i timbri originali delle località del percorso.

3. Sicurezza e Salute
- Acqua e cibo: porta sempre con te almeno 2 litri d’acqua. Alcune tappe del cammino potrebbero non avere fonti facilmente accessibili, quindi, è importante rifornirsi nelle tappe principali. Non dimenticare di portare anche snack energetici come frutta secca, barrette di cereali e noci.
- Protezione solare: il sole del sud Italia può essere molto forte, soprattutto in estate. Usa una crema solare con protezione alta, occhiali da sole e un cappello.
- Riposo: ascolta il tuo corpo. Non esitare a fare delle pause e a riposarti quando necessario. I muscoli e le articolazioni possono soffrire durante il cammino, ecco perché prendersi dei momenti di recupero è importante.
Articolo pubblicato nell’ambito dell’intervento: Fondo Sviluppo e Coesione – Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del Ministero italiano della cultura (Scheda 33 – Via Francigena – Azioni trasversali. Trasmissione scheda progetto “Piano di comunicazione e promozione)